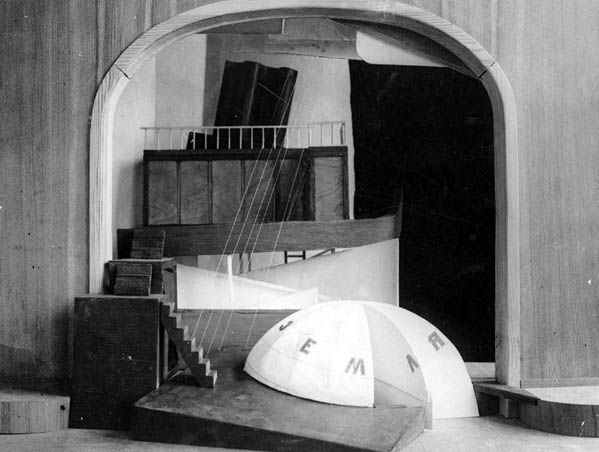La definizione dell’individuo che si fonda sul principio di autoaffermazione e di riuscita professionale fa riferimento a una particolare etica del lavoro che risponde al valore dell’efficientismo produttivistico, funzionale al mantenimento di una società neoliberista.[1] Per l’antropologo Victor Turner la società contemporanea si distingue da quella tradizionale proprio per aver prodotto una cesura tra lavoro e svago che ha finito per sacralizzare il lavoro e demonizzare la dimensione ludica, rituale e potenzialmente sovversiva della vita.[2] Tradotto in chiave neoliberista, la sacralizzazione del lavoro si unisce al monito di efficacia del sé e trova sbocco nell’ossessione carrieristica, nella professionalizzazione continua, nella spinta all’iperqualificazione e in una formazione che abbracci tutto il ciclo di vita.
Nell’era della crisi occupazionale e della precarizzazione delle condizioni lavorative, il mito teologico della dedizione al proprio lavoro si trasforma in una vera e propria esaltazione acritica della flessibilità e dell’innovazione come qualità fondamentali per rispondere alle attuali richieste aziendali in un mercato del lavoro sempre più volatile, incerto ed instabile. Ma se da un lato il crollo delle certezze che caratterizzavano i percorsi educativo-professionali e garantivano una relativa stabilità lavorativa determina una generale fragilizzazione delle condizioni socioeconomiche, dall’altro sembra reggersi su un nuovo ordine di valori che considera la stabilità e la sicurezza professionali come indizi di un’indole debole, pigra e conservatrice, che teme di mettersi alla prova rifiutando ogni possibilità di cambiamento. Allo stesso tempo, secondo la più classica logica antropocentrica, l’individuo continua a essere considerato l’artefice del proprio destino, ignorando il ruolo delle circostanze biografiche e delle condizioni socioeconomiche di partenza. Egli risulta così indebitamente responsabilizzato rispetto alle proprie chance di successo nell’opera di autodefinizione e autoaffermazione in cui è esortato a impegnarsi.
La crisi delle definizioni tipica della nostra società “liquida”,[3] sebbene possa conservare i tratti della liminalità, non è affatto una fase transitoria che apre a nuovi scorci e a diversi criteri di soggettivazione. Questa crisi diventa strutturale e insita al sistema culturale postmoderno: essa testimonia dell’aleatorietà e della convenzionalità delle definizioni, in virtù di un principio di libertà incondizionata che assegna all’individuo il pieno potere di autodefinirsi e autorealizzarsi. Ma secondo la definizione di Turner, ch’egli riprende da Van Gennep,[4] la liminalità è una condizione provvisoria, nata dalla rottura di un equilibrio precedente e avente in sé l’anelito al cambiamento e alla costruzione di un equilibrio ulteriore. Di conseguenza, se la liminalità si dilata in un tempo infinito e indefinito perde il suo potere liminale, creativo, ludico e liberatorio, diventando una nuova prigione, una condizione di sospensione congelata in cui l’individuo perde le basi per costruire un’immagine di sé nella quale possa riconoscersi ed essere riconosciuto.
Così, se da un lato il sé resiste alle eterodefinizioni che la società del passato imponeva all’individuo, dall’altro l’idea che la

definizione del sé, per quanto autonomamente costruita, sia rigida e sostanzializzata permea ancora le nostre concezioni di fondo e i processi di soggettivazione socialmente riconosciuti come possibili e legittimi. E’ come se ci trovassimo in una fase di transazione tra due concezioni del sé che, metaforicamente, potremmo definire l’una parmenidea e l’altra eraclitea. Nel mondo di Parmenide l’essere è immobile e immutabile perché ogni passaggio di stato scopre lo spettro del nichilismo: se l’essere è e non può non essere, allo stesso modo il sé é sempre e solo sé e non può essere altro da sé. E’ questa definizione rigida del sé che troviamo implicita nel concetto di identità: il sé é sempre identico a se stesso, senza scorrimenti né trasformazioni. I confini dell’identità sono rigidi; il sé concepito come identità diventa un ente sostanziale. Nel mondo di Eraclito, invece, l’essere non si dà che all’infinito, privo com’é di confini strutturati e rigide definizioni. Nessun ente può mantenersi identico a se stesso. Se volessimo definire il sé secondo tale prospettiva ci troveremmo quindi in un vero e proprio vicolo cieco: sé e identità non potrebbero conciliarsi e la stessa consistenza del sé come un ente fra gli enti, come soggetto tra gli oggetti, sarebbe del tutto impensabile. Anzi, in un mondo dove niente resta costante e stabile, la nozione stessa di identità perderebbe consistenza ontologica e validità logica.
Ma l’era della postmodernità non si è affatto sbarazzata della nozione d’identità. Da questo punto di vista, l’influsso cartesiano pregno di una certa qual fede razionalista e logocentrica, sembra ancora perdurare. L’enfasi sul cogito in quanto sostanza immateriale ha prodotto un’identificazione del tutto particolare tra anima ed identità nella quale infondo crediamo ancora oggi. Da qui, l’identità diventa l’essenza stessa della soggettività. Così come Parmenide pensava che il mutamento dell’essere implicasse l’insorgere del nulla, l’individuo che cerca se stesso, sulla scorta delle molteplici possibilità d’identificazione, teme di perdersi, sentendosi invaso dal terrore della morte. Per tale ragione, l’individuo contemporaneo convive con l’angoscia radicale della perdita del sé. La sua paura più grande è l’annientamento del proprio statuto di soggetto.
Le infinite possibilità di autodefinizione, che si perpetuano potenzialmente dalla nascita fino alla morte, se da un lato ribadiscono l’espansione esponenziale delle nostre libertà, dall’altro ci vincolano alla loro normatività intrinseca. Essere liberi, per effetto di un strano assurdo doppio-legame, diventa un dovere, per non dire un’oppressione. In altre parole, quello che a prima vista può sembrare un diritto di emancipazione del soggetto, si tramuta in ingiunzione. Questa ingiunzione paradossale è stata ben chiarita da Erembergh in La fatigue d’etre soi, un testo che, pur nella sua non proprio recente pubblicazione, si rivela ancora oggi illuminante. La prima edizione francese risale infatti al 1998, ma da allora numerose altre versioni e traduzioni sono state riproposte e il saggio è diventato famoso per aver spiegato la natura storico-sociale della depressione e le ragioni della sua elevata diffusione.[5] Per Erembergh, la società occidentale produce un gap di autostima perché da un lato, riposando su un’organizzazione socio-economica fondata sull’efficientismo e la performatività del sé, propone modelli di successo troppo alti e difficilmente raggiungibili, mentre dall’altro esorta l’individuo ad affermare se stesso esaltando i miti del successo e inducendolo a reiterare quei valori di autoefficacia, produttivismo e potenziale consumistico che sono alla base della società neoliberista e dell’economia di mercato.

Così l’istituzione individualista, proprio mentre celebra la libertà dell’uomo di autodefinirsi come soggetto autonomo e irriducibile, esorta l’individuo ad adeguarsi a tale libertà secondo la norma dell’individualizzazione. In altre parole, l’individualismo disegna i contorni di una particolare struttura sociale, venendo a configurarsi come una delle tante modalità di socializzazione e disciplinamento dell’individuo. Si produce quindi, tanto per il soggetto quanto in seno all’intera collettività, un paradosso implicito : l’individuo deve essere libero. E qual è la libertà primaria dell’individuo che fonda e legittima tutte le altre? Ebbene si tratta della libertà di essere se stessi che si riduce nella spinta ad emanciparci da qualsivoglia condizionamento sociale. Ma per essere se stessi occorre innanzi tutto – sulla scia dell’antico motto socratico-agostiniano – conoscersi. Nella società contemporanea l’individuo non è considerato tale se non possiede la consapevolezza piena di chi è e di chi vuole essere, delle proprie capacità e dei propri limiti, sempre suscettibili di essere superati grazie a un impegno e a un’applicazione che sconfina in una definizione aperta e mai rigida di un sé che tuttavia continua a venir definito in termini d’identità.
In questa ansia teleologica verso un sé irraggiungibile, proiettata verso un futuro sempre più incerto e inconsistente, si opera una vera e propria trascendizzazione del concetto d’identità: l’identità è come divinizzata, posta al di fuori dello spazio e del tempo umani, utopia ultramondana o profezia sacrale. Secondo una terminologia che risale alla psicologia sociale e trae origine dal pragmatismo americano di William James, il sé reale tende ad adeguarsi al sé ideale per regalarci un livello sempre più elevato e gratificante di autorealizzazione.[6] Il senso di autostima, stando a questa spiegazione, sarebbe inversamente proporzionale alla discrepanza tra queste due immagini del sé: ciò che si pensa di essere e ciò che si vuole essere. Ora, i filosofi e gli psicologi del sé sociale, erano d’impronta interazionista, convinti assertori dell’interazione tra individuo e società nella costruzione dell’identità;[7] non erano certo razionalisti cartesiani e implacabili reificatori dell’io. Ciononostante, questi concetti sono stati elaborati e messi in circolazione in una società abituata a pensare al sé in termini di entità cosale autosufficiente e incausata. Ciò ha inconsapevolmente prodotto l’idea che l’identità debba essere il risultato finale di un processo performativo che culmina con il conseguimento dell’io reale volto ad adeguarsi al sé ideale, o in altri termini, con il mito dell’autenticità dell’io.
E’ stato Foucault[8] a sottoporre in modo perentorio e definitivo la nozione di soggettività al vaglio della critica. Infatti, grazie

alla sua consueta furia analitica, riesce a decostruire il pensiero comune, docile compagno vessato della dominazione: rintracciando le ragioni genealogiche[9] di quelle rappresentazioni così radicate da risultare ovvie, egli ne dimostra l’inconsistenza ontologica, demistificando la fede dogmatica nella loro esistenza. In questo modo egli ha saputo mettere in luce che la nozione di soggetto in quanto ente autonomo, contrapposto all’oggetto e finalmente libero dall’assoggettamento al potere, non è che il frutto di una configurazione (ideo)logica (di un episteme) pregna di mistificazioni e idealizzazioni storicamente determinatesi. In altre parole, per Foucault l’emergere del soggetto, la sua emancipazione dalle dinamiche del potere, è una pura illusione antropocentrica dagli echi cartesiani e razionalistici. Il soggetto, infatti, non è solo soggetto di azione ma anche e innanzitutto soggetto al potere: soggetto e suddito a un tempo.[10] In atri termini, nel processo di soggettivazione in cui l’individuo s’impegna, non vi è mai una piena e totale emancipazione del soggetto. Ogni processo di soggettivazione è infatti radicato in un ordine di valori e di rapporti di potere che lo giustifica e lo sorregge.
Le figure della desoggettivazione sono estremamente importanti anche per definire i processi di soggettivazione che vengono legittimati in seno a una determinata società e secondo un ordine di valori ad essa coerente. L’individuo per diventare soggetto deve poter riconoscere e identificare i propri fantasmi, le figure nelle quali teme terribilmente di potersi un giorno ridurre. Sono proprio queste figure che abbiamo chiamato idealtipi della desoggettivazione. Ma in una società in cui il processo di soggettivazione socialmente legittimo si fonda sul valore dell’autoaffermazione, il vero dramma che annienta e terrorizza l’individuo contemporaneo è la perdita prematura del sé, vissuta come il presagio di una morte annunciata. E’ Alfred l’anti-soggetto per eccellenza, l’idealtipo che incarna e rappresenta la forma più estrema di desoggettivazione che la nostra società ha prodotto. La demenza senile ci offre il quadro interpretativo più calzante per inquadrare l’angoscia radicale del pensiero postmoderno, il terrore della perdita del sé.
Note.
[1] Del resto, non è un fatto nuovo che etica ed economia siano strettamente legate e s’influenzino reciprocamente. Un’analisi sociologica di questo tipo è ormai classica e risale ai tempi in cui Max Weber, in L’Etica protestante e lo spirito del capitalismo, ha saputo illuminare le dinamiche di rapporti e interconnessioni tra l’orizzonte culturale e assiologico e il piano delle pratiche e delle tecnologie di produzione che s’inscrivono in quel determinato orizzonte di significati e di valori. Del resto l’etica altro non è che il corpus di condotte che vengono prescritte in base a un’articolazione di valori e credenze poste a loro giustificazione e fondamento.
[2] TURNER, Victor, Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 79-80 (ed. originale, From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, John Hopkins University Press, Baltimora, 1982).
[3] BAUMAN, Zygmunt, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002 (ed. originale: Liquid Modernity, Polity, The University of Chicago Press, Chicago, 2000).
[4] VAN GENNEP, Arnold, Les rites de passage, Picard, Paris, 1909
[5] EHREMBERG, Alain, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi, Torino, 1999 (ed. originale: La fatigue d’etre soi. Dépression et société, Odile Jacob, Paris, 1998).
[6] LEWIN, Kurt, Teoria dinamica della personalità, Giunti, Milano, 2011 (ed. originale: A Dynamic Theory of Personality, MHE, New York, 1935).
[7] HERBERT-MEAD, George, The Individual and the Social Self, University of Chicago Press, Chicago, 1982.
[8] FOUCAULT, Michel, La volonté de savoir, Histoire de la sexualité, tome I, Gallimard, Paris, 1976.
[9] Foucault ha elaborato un metodo di analisi che non è riducibile alla sola disamina storica, proponendosi invece di rintracciare quell’archeologia del sapere che fada matrice e da sfondo alle concezioni consolidate, nate da un determinato ordine di potere, servono a reiterare saperi, pratiche, tecnologie e rapporti di forza che confermano lo status quo. Sulla base di questa ricerca archeologica egli elabora poi una genealogia delle rappresentazioni che, sulla scorta della genealogia della morale ripresa da Nietzsche, individua o snodi e punti di svolta nel processo storico che ha portato al loro attuale consolidamento. Si tratta dei due metodi speculativi che guidano tutta la ricerca foucaultiana. L’archeologia è il metodo che porta alla luce quel sapere implicito alla società (episteme) che fonda tutte le istituzioni, le pratiche, i saperi, i valori e i giudizi prodotti in un determinato orizzonte. La genealogia è intesa come l’analisi delle pratiche e dei saperi che hanno determinato l’evoluzione di un determinato meccanismo di potere. Per l’approfondimento si rimanda a FOUCAULT, Michel, L’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1970.
[10] FOUCAULT, Michel, La volonté de savoir, Histoire de la sexualité, tome I, Gallimard, Paris, 1976, p. 58.