I prodotti seriali costituiscono a oggi la forma di intrattenimento più diffusa nella produzione audiovisiva; si riscontra, in particolar modo, da un paio d’anni, con l’avvenuta affermazione di accessi a servizi di streaming online on demand, in grado di coinvolgere milioni di spettatori in tutto il mondo. Proprio la fruizione meccanica di una sempre più affermata forma di serie serializzata[1], per dirla con Pescatore, a cui lo streaming ci abitua (al contrario della temporalità diluita a cui si rifà l’impostazione dettata dal palinsesto, più propria del serial televisivo[2]), si inscrive all’interno di quello che si è ormai formato quale fenomeno dell’istantaneità del tecnologico connesso a pratiche di visione o meglio, alla visibilità permessa dai differenti schermi neri che caratterizzano la società contemporanea, obbligata a una connessione continua.
La serialità televisiva quale parte di una realtà, ma anche narrazione della realtà. Speriamo qui nel dare qualche spunto di riflessione affermando come lo storytelling che contraddistingue le più recenti narrazioni seriali, compie una lettura dell’odierno: analizzando situazioni, spesso portando all’estremo, offre spunti per comprendere le trasformazioni a cui la nostra società costantemente è sottoposta, in particolar modo attraverso tecnologia, distopia e satira -tre elementi che paiono a noi caratterizzare fortemente la narrazione seriale audiovisiva contemporanea-. Pensare tra gli altri a 24 (2001-2010), Alias (2001-2006), Homeland (2011-), Quantico (2015-), Scandal (2012-), quale prova singolare, casi esemplari di quella serialità che, come si accennava, va a trattare proprio la relazione che intercorre tra istantaneità e tecnologia, in forma di denuncia, per tratti satirica, nei confronti della società contemporanea. Capostipite indiscussa di queste narrazioni rimane la seguitissima serie di Black Mirror. Ideata e prodotta da Charlie Brooker, la serie televisiva britannica viene oggi considerata un fenomeno di culto nella produzione seriale; se ne va a sondare alcuni motivi.
Particolare nella sua configurazione, la produzione in esame è caratterizzata dall’assenza di ripetizione e ritorno: una serie antologica dove non vi è continuità spazio-temporale. Ogni episodio ha un cast differente, un’ambientazione diversa.
Lo schermo nero, come si evince dal titolo della serie, ritorna in tutti gli episodi delle tre stagioni[3] sino a ora diffuse: unico fil rouge della produzione, come afferma Brooker è il display che troviamo «su ogni parete, su ogni scrivania, nel palmo di ogni mano»[4]; ma quali gli effetti collaterali di questa presenza così irruente? Ogni singolo episodio va a sondare una sfaccettatura di tale fenomeno e, seppur spesso enfatizzando, denuncia gli esiti di un utilizzo improprio degli apparecchi che alimentano il dispositif inteso in chiave foucaultiana, le stesse tecnologie che utilizziamo nel nostro quotidiano, che sono parte integrata ormai del funzionamento della società, secondo accezione deleuziana, di controllo. Scopo della produzione risulta essere proprio sondare l’incedere e il progredire delle nuove tecnologie, l’assuefazione a esse: come ricorda Manovich[5], l’interattività con il mondo, dettata da software multimediali quali protesi della nostra memoria quanto della nostra immaginazione, che divengono linguaggio universale attraverso cui l’intero globo comunica: ecco perché «tutti (gli episodi della serie) riguardano il modo in cui viviamo ora»[6] colpendo le coscienze e la sensibilità di un pubblico così vasto.
Nella rappresentazione di una società iperconnessa, caratterizzata da una tecnologia da definire paradossale, gli effetti collaterali che destabilizzano il vissuto quotidiano, così come li racconta Brooker, non sono così lontani a quelli che i diversi apparecchi scopici utilizzati oggi provocano nella società odierna, in particolar modo rispetto un’azione quale mostrare il vedere, sia intesa quale costruzione sociale della visione attuata attraverso tecnologie, sia operazione di quella che è la costruzione visuale di un singolo individuo nel suo quotidiano: i risvolti che scaturiscono dalla relazione di queste due facce della stessa medaglia offrono differenti prospettive di analisi di quella che è una spettacolarizzazione dell’occhio orwelliano e la messa in scena del singolo quale corpo in movimento, vero oggetto di quel controllo sorvegliante: pensiamo ai personaggi di 15 Millions of Merits che per uscire dalla realtà-prigione in cui vivono devono partecipare a un talent show o ancor più Kenny, il protagonista di Shut Up and dance obbligato a rispondere ad alcune ‘prove’ in cambio del silenzio di un hacker venuto in possesso di immagini compromettenti.
Negli ultimi anni, soprattutto dopo gli eventi dell’11 Settembre 2001, la trasmissione di dati e l’accessibilità di questi tramite apparecchi mobili con funzioni locative e, l’aumento di presenza da parte d’un occhio sorvegliante sui singoli, processi atti ad alimentare il cosiddetto dispositivo scopico, hanno rimodellato il concetto di spazio urbano e le relazioni tra individui all’interno di una tangibilità di bits. Questa seppur rinvenuta modalità di controllo sui corpi, mascherata da un’esigenza di sicurezza nazionale, propria degli ultimi quindici anni, trova radici sin dalle teorizzazioni di Michel Foucault relative alle società disciplinanti, e in particolar modo nelle pagine del suo studio più conosciuto, Sorvegliare e Punire[7], in cui il filosofo francese riprende il modello Panopticon ideato dal riformatore britannico Jeremy Bentham. L’architettura pensata nel corso dell’800 per il controllo continuo e totale dei corpi da disciplinare è riconosciuto dalla critica come precursore del sistema attuale di classificazione dell’individuo, secondo atteggiamenti e scelte quotidiane; se il Panopticon prevedeva uno sguardo mirato e circoscritto, oggi il corpo dell’individuo ‘da sorvegliare’ è oggetto di un occhio assoluto della presenza costante di schermi neri capace di seguire ogni spostamento nello spazio, riprodurre la tangibilità dei corpi in immagini di videosorveglianza o dati di tracciabilità: Black Mirror ci porta a nostro avviso, a ragionare su come la trasformazione tecnologica in divenire, a cui l’intermedialità ci obbliga, non sarà una sostituzione delle modalità di visione (sorvegliante in primis), ma un potenziamento delle modalità adottate, in questo caso verso il digitale. Il controllo grazie alla tecnologia diviene spettacolarizzazione della realtà in cui il confine tra Sé e replica di Sé a volte sfuma: si rivive come algoritmo, nel cloud, nei device che usiamo e nei dati che produciamo.
In White Bear (Orso Bianco) accade proprio questo; si tratta di una narrazione il cui soggetto principale è proprio l’assenza di distinzione tra vita pubblica e privata, in una totale sovrapposizione. Una meravigliosa metafora della condizione umana che avviene in una struttura che rimembra un macabro parco dei divertimenti. L’azione si rivelerà essere il retroscena di uno show, a cui la protagonista, Victoria Skillane, è condannata; uno spettacolo che fa della punizione di un crimine, una pubblica visione che leggiamo quale potenzimento delle pratiche punitive nelle piazze medievali: il lato oscuro del controllo oggi, in cui, il potere della società della sorveglianza, connesso al mass mediatico, è riassumibile proprio nell’idea di tribunale fatto da tutti, a cui partecipano tutti, una giustizia che Fabio Chiusi afferma essere vicina a quella di un reality tv[8]. Ed è proprio all’interno di un programma televisivo (lo scopriremo solo alla fine) che avviene l’azione narrata dall’episodio. Victoria avrebbe rapito insieme al ragazzo una bambina, torturata dall’uomo e poi uccisa mentre lei riprendeva il fatto. In una sorta di legge del contrappasso, le pene che a loop le verranno inferte figurano quali funzioni disciplinanti nella società (un po’ come lo era l’esperienza panottica) dove gli ingredienti dello spettacolo della punizione rinvenibile negli usi di una tecnologia scopica, si fondono per dare vita alla dinamica della pena.
La donna viene inseguita nella sua corsa da un numero di persone, resi zombi tecnologici dal segnale del trasmettitore ‘Orso Bianco’, che continuano a filmarla con il proprio telefonino, insensibili a ciò che sta accadendo, impassibili allo spavento: una sorta di Synopticon[9], nell’accezione del sociologo Thomas Mathiesen, una rivisitazione panottica in cui il controllo si fa fenomeno decentrato e capillare, la sorveglianza dei molti sui molti, quella che viene definita dagli studi di società di controllo una sousveillance, sorveglianza dal basso, in cui tutti, come viene affermato nell’episodio in esame, hanno un pubblico! Insieme alla protagonista, altri come lei, paiono minacciati (si scoprirà successivamente che si trattava di attori parte del cast) da persone che costantemente filmano lo spazio circostante: «Spesso restano davanti alla finestra a spiarci» dice una di loro a Victoria, riferendosi agli uomini che inspiegabilmente riprendono. «Sono sicura che è così che ci trovano. O anche con quelle telecamere. Ti individuano e in un attimo appaiono gli altri bastardi armati».

Satira atroce e forse selvaggia della società del controllo spettacolarizzato, termina con la consapevolezza della protagonista di essere oggetto di un dantesco castigo, soggetto di uno sguardo pubblico che continua a vituperare ‘l’assassina’, un occhio che richiama, seppur all’esasperazione, il dispositivo scopico che ci appartiene, che noi stessi alimentiamo in uno utilizzo continuo e massivo di apparecchi tecnologici. Grazie all’utilizzo di elettrodi, verrà cancellata la memoria della protagonista condannata, come in un vortice, a essere oggetto di uno sguardo continuo; l’episodio terminerà laddove è iniziato: Victoria si sveglierà senza ricordare nulla all’interno di una continua ripetizione.
Nell’ultima stagione a oggi diffusa, un secondo episodio richiama alla mente la punizione disciplinante inferta dal tribunale di tutti: Hated in the Nation (Odio universale). La morte di una giornalista Jo Powers, attira l’attenzione della detective Parke e dell’esperta informatica Blue Colson. L’autopsia rivela che l’omicidio possa essere causato da un insetto drone automatizzato (IDA) a sembianza di api, genere, nella società che Brooker ci narra, in estinzione.

Stesso modus operandi per il rapper Tusk. Elemento in comune tra i due? Entrambe vittime de il ‘Gioco delle conseguenze’; il quantitativo di messaggi similari a un twitter con hashtag #DeathTo pare determinare la morte di un personaggio pubblico. Scoperto l’arcano dal pubblico stesso che alimentava inconsapevolmente tale giostra dell’orrore, l’utilizzo dell’hashtag, divenendo fenomeno virale del web, aumenta rapidamente, mirato verso una terza possibile vittima. Solo successivamente l’agente governativo Lì confesserà l’esistenza di un sistema di controllo da parte del governo tramite i droni ADI: una forma di sorveglianza di massa nei confronti della popolazione che diviene controllo nell’attimo in cui viene a essere proprietà di un hacker nero. Una società del controllo con fini di sicurezza, come teorizza Deleuze, in cui:
«Non c’è bisogno della fantascienza per concepire un meccanismo di controllo che dia in ogni momento la posizione di un elemento in ambiente aperto, animale in una riserva, uomo in una impresa (collare elettronico). […] Ciò che conta non è la barriera ma il computer che ritrova la posizione di ciascuno, lecita o illecita, ed opera una ‘modulazione universale’»[10].
Così come, lo abbiamo visto in precedenza, l’apparecchio del quotidiano non si limita più a un utilizzo privato per cui viene inizialmente pensato, anche il drone non è più solo arma militare, ma rappresenta uno dei differenti mezzi attraverso cui risultiamo esseri costantemente esposti, oggetti dell’aggressività di un occhio penetrante, atto a riconfigurare non solo la condotta materiale della violenza, ma tecnicamente, tatticamente, psichicamente l’agire dell’intera società.
[1] G. Pescatore, I. Innocenti (a cura di), Introduzione alla serialità televisiva, Archeolibri, Bologna 2008.
[2] La distinzione che intercorre tra le serie e i serial televisivi è determinata, più che dalla narrazione, da una diversa articolazione temporale degli elementi narrativi. Il serial televisivo, meglio conosciuto come soap opera è contraddistinto da una scansione di puntate la cui conclusione non è definitiva ma lascia suspense –cliffhanger– nello spettatore, che incuriosito, sarà condotto a seguire la puntata successiva.
[3] Prima stagione (2011): The National Anthem, ep. 1; 15 Millions of Merits, ep. 2; The Entire History of You, ep. 3. Seconda stagione (2013): Be Right Back, ep. 1; White Bear, ep. 2; Vote Waldo! ep. 3. Terza stagione (2016): Nosedive ep.1; Playtest ep.2; Shut Up and dance ep.3; San Junipero ep.4; Men Against Fire ep.5; Hated in the Nation ep. 6.
[4] http://tinyurl.com/pzuqwts
[5] L. Manovich, Software culture, Olivares, Milano 2010.
[6] http://tinyurl.com/pzuqwts
[7] M. Foucault, Sorvegliare e Punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2014.
[8] F. Chiusi, Dittature dell’istantaneo. Black Mirror e la nostra società iperconnessa, Codice edizioni, Torino 2014, p.100.
[9] T. Mathiesen, The viewer society: Michel Foucault’s ‘panopticon’ revisited, in «Theoretical Criminology », 1, 1997, pp. 215-234.
[10] G. Deleuze, Postscritto sulle società di controllo in, Pourparler, Quodlibet, Macerata 2000.


 Nella produzione teatrale e cinematografia, i protagonisti non sono certo immediatamente riconoscibili nei personaggi sofoclei, ma si tratta di giovani uomini ‘moderni’ che scelgono di disobbedire alla legge dei mondi. A teatro, nel 1932, pièce inspirata dalle vicende edipiche è La machine infernale
Nella produzione teatrale e cinematografia, i protagonisti non sono certo immediatamente riconoscibili nei personaggi sofoclei, ma si tratta di giovani uomini ‘moderni’ che scelgono di disobbedire alla legge dei mondi. A teatro, nel 1932, pièce inspirata dalle vicende edipiche è La machine infernale «Plan du Sphinx. Le Sphinx au tronc féminin agite lentement ses longues ailes de plumes blanches et glisse le long d’un mur à pic sur le paysage du Val d’Enfer. Le poète le dèpasse sans que ses yeaux artificiels puissent le voir. Plan d’Oedipe. Oedipe aveugle, appuyé sur Antigopne, sort d’une des portes de Thèbes en chuchotant des paroles incompréhensibles. Il croisele poète qui s’éloigne sans l’avoir vu»
«Plan du Sphinx. Le Sphinx au tronc féminin agite lentement ses longues ailes de plumes blanches et glisse le long d’un mur à pic sur le paysage du Val d’Enfer. Le poète le dèpasse sans que ses yeaux artificiels puissent le voir. Plan d’Oedipe. Oedipe aveugle, appuyé sur Antigopne, sort d’une des portes de Thèbes en chuchotant des paroles incompréhensibles. Il croisele poète qui s’éloigne sans l’avoir vu» Il legame tra mondo umano e mondo dell’oltretomba si manifesta in forma di legame amoroso. Nel film Orphée, Orfeo si innamora della Princesse, una sorta di affascinante e mondana Parca, braccio della Morte. Questa traversata di luoghi proibiti in cerca della donna amata rappresenta anche un viaggio verso l’Inconnu, luogo dove gli uomini scrivono i loro sogni e i loro desideri, la terra degli eroi mitologici e dei poeti. Il viaggio di Orfeo è strumento di rigenerazione, metamorfosi, rinascita, quella scienza definita fenixologia, ovvero la capacità del poeta di morire molte volte per poi risorgere dalle sue stesse ceneri; e questo potrà avvenire solo grazie all’amore dell’Uomo verso la Princesse che nel corso del viaggio lo porterà a ricordare la vera essenza della sua Poesia, della sua opera. Nascere per poter ri-vivere, ri-creare. Nel film Le testament d’Orphée, nonostante il cineasta affermi più volte che nell’opera non vi sia alcun legame con la mitologia orfica, la ‘fenixologia’ è alla base del percorso del poeta interpretato da Jean Cocteau stesso. Questi deve vivere diverse vite e attraversare diversi varchi spazio-temporali prima di raggiungere la dea Atena. Deve poi portare con sé un fiore di Ibisco donatogli da Cégeste che, risorto dalle acque marine, afferma che «Cette fleur est faite de votre sang, elle épouse le syncopes de votre destin»; un fiore era già stato protagonista de La Belle et la Bête: una rosa, simbolo della poesia. Certo non si tratta di riportare alcuna amata al mondo dei vivi, ma vi è un reale viaggio, in un luogo le cui soglie marmoree richiamano l’ideale soglia agli Inferi. In più si rileva la presenza di molti dei personaggi che hanno caratterizzato la genesi del mito nell’opera precedentemente ricordata, qui riproposti. Cégeste in primis, il cavallo (presente nella pièce e divenuto poi Roll-Royce nel film), Heurtebise e infine la Princesse che condannati dal Tribunale degli Inferi a giudicare in eterno, si ritrovano ora ad accusare lo stesso Cocteau, colpevole di aver compiuto atti contro la Legge divina.
Il legame tra mondo umano e mondo dell’oltretomba si manifesta in forma di legame amoroso. Nel film Orphée, Orfeo si innamora della Princesse, una sorta di affascinante e mondana Parca, braccio della Morte. Questa traversata di luoghi proibiti in cerca della donna amata rappresenta anche un viaggio verso l’Inconnu, luogo dove gli uomini scrivono i loro sogni e i loro desideri, la terra degli eroi mitologici e dei poeti. Il viaggio di Orfeo è strumento di rigenerazione, metamorfosi, rinascita, quella scienza definita fenixologia, ovvero la capacità del poeta di morire molte volte per poi risorgere dalle sue stesse ceneri; e questo potrà avvenire solo grazie all’amore dell’Uomo verso la Princesse che nel corso del viaggio lo porterà a ricordare la vera essenza della sua Poesia, della sua opera. Nascere per poter ri-vivere, ri-creare. Nel film Le testament d’Orphée, nonostante il cineasta affermi più volte che nell’opera non vi sia alcun legame con la mitologia orfica, la ‘fenixologia’ è alla base del percorso del poeta interpretato da Jean Cocteau stesso. Questi deve vivere diverse vite e attraversare diversi varchi spazio-temporali prima di raggiungere la dea Atena. Deve poi portare con sé un fiore di Ibisco donatogli da Cégeste che, risorto dalle acque marine, afferma che «Cette fleur est faite de votre sang, elle épouse le syncopes de votre destin»; un fiore era già stato protagonista de La Belle et la Bête: una rosa, simbolo della poesia. Certo non si tratta di riportare alcuna amata al mondo dei vivi, ma vi è un reale viaggio, in un luogo le cui soglie marmoree richiamano l’ideale soglia agli Inferi. In più si rileva la presenza di molti dei personaggi che hanno caratterizzato la genesi del mito nell’opera precedentemente ricordata, qui riproposti. Cégeste in primis, il cavallo (presente nella pièce e divenuto poi Roll-Royce nel film), Heurtebise e infine la Princesse che condannati dal Tribunale degli Inferi a giudicare in eterno, si ritrovano ora ad accusare lo stesso Cocteau, colpevole di aver compiuto atti contro la Legge divina.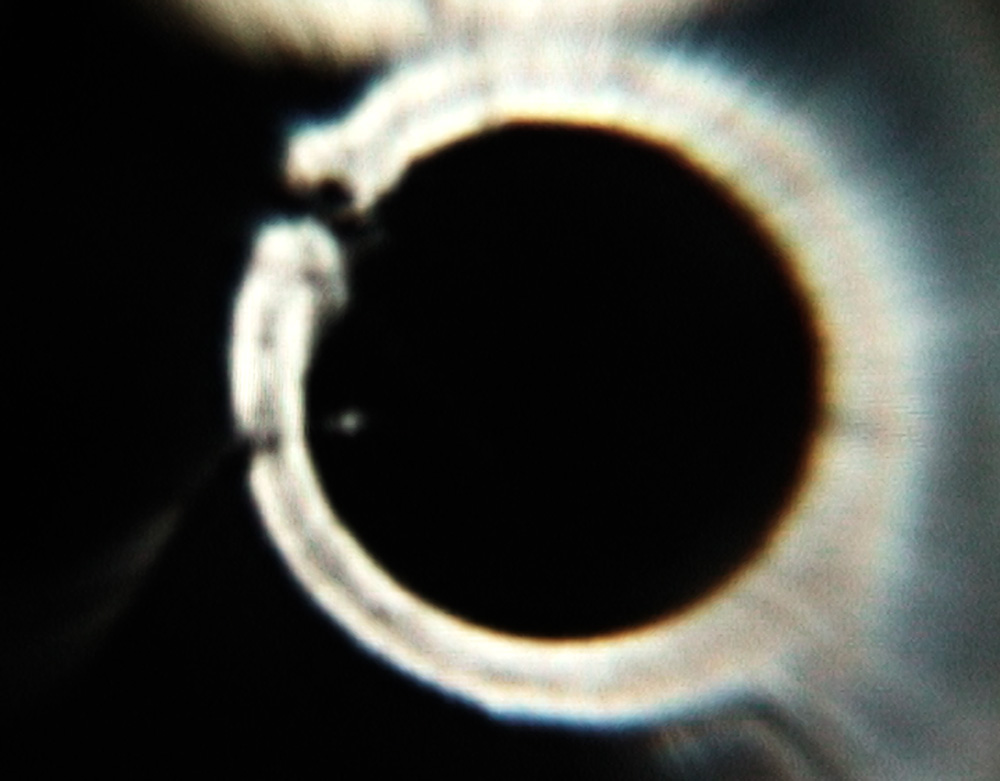

 L’anno successivo una produzione estrema e ricercata, in cui Boccassini lavora su materiale visivo della Prima Guerra Mondiale, già esistente. Mettendo in evidenza la relazione tra lo Sguardo e la Memoria, The tin hat (2014) ci permette di vedere, e quindi prendere coscienza, una realtà storica. L’idea del cortometraggio, non a caso, parte dalla considerazione di Tacito: ‘la guerra è il luogo in cui l’occhio viene per primo soggiogato’. L’argomento bellico funge così a essere filtro, secondo nostra opinione, di una questione ancor più spinosa connessa inevitabilmente allo sguardo contemporaneo.
L’anno successivo una produzione estrema e ricercata, in cui Boccassini lavora su materiale visivo della Prima Guerra Mondiale, già esistente. Mettendo in evidenza la relazione tra lo Sguardo e la Memoria, The tin hat (2014) ci permette di vedere, e quindi prendere coscienza, una realtà storica. L’idea del cortometraggio, non a caso, parte dalla considerazione di Tacito: ‘la guerra è il luogo in cui l’occhio viene per primo soggiogato’. L’argomento bellico funge così a essere filtro, secondo nostra opinione, di una questione ancor più spinosa connessa inevitabilmente allo sguardo contemporaneo.








