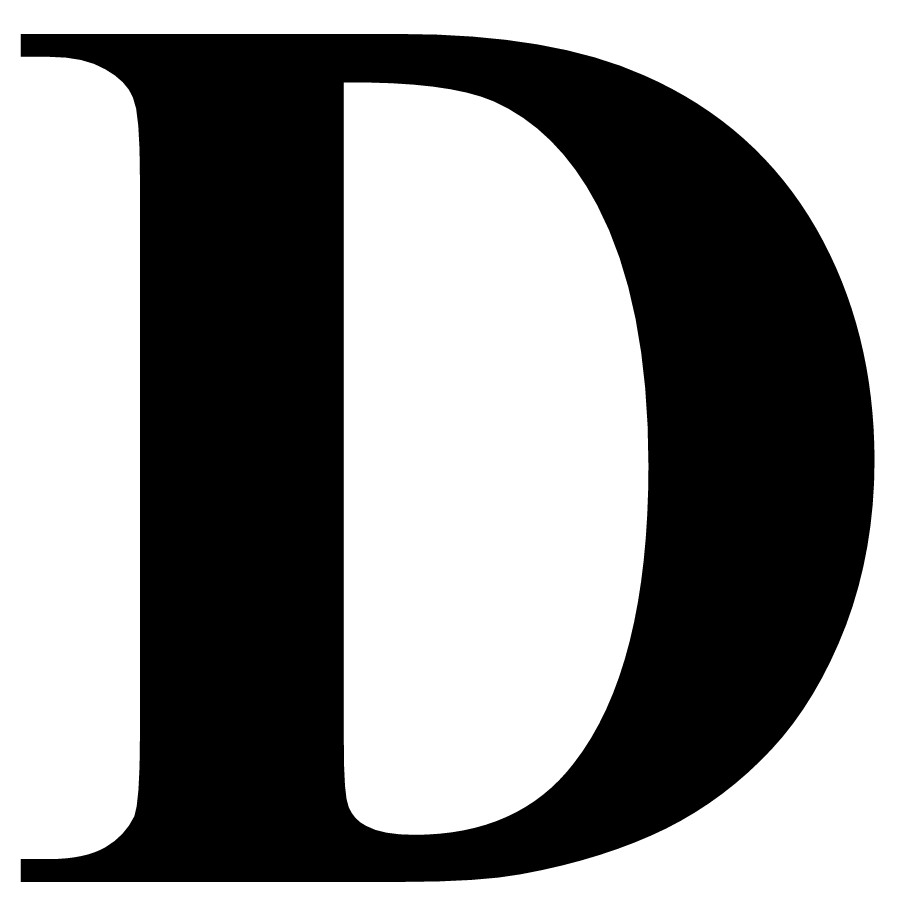 al punto di vista dei soggetti implicati nella commemorazione, la violenza estrema è inserita nella categoria esplicativa dell’attentato terrorista di matrice islamica. Già all’indomani degli attentati di gennaio, l’opinione pubblica francese ed europea aveva adottato un’ermeneutica rigidamente manichea opponendo l’identità democratica, laica e liberale alla barbarie jihadista.[1] In questo modo, la prima cerimonia di commemorazione ha immediatamente inserito un elemento di discriminazione antropologica, ridefinendo il confine tra l’umanità delle vittime (e di coloro che ne onorano il ricordo) e la mostruosità dei carnefici.
al punto di vista dei soggetti implicati nella commemorazione, la violenza estrema è inserita nella categoria esplicativa dell’attentato terrorista di matrice islamica. Già all’indomani degli attentati di gennaio, l’opinione pubblica francese ed europea aveva adottato un’ermeneutica rigidamente manichea opponendo l’identità democratica, laica e liberale alla barbarie jihadista.[1] In questo modo, la prima cerimonia di commemorazione ha immediatamente inserito un elemento di discriminazione antropologica, ridefinendo il confine tra l’umanità delle vittime (e di coloro che ne onorano il ricordo) e la mostruosità dei carnefici.
Non a caso le prime due risposte politiche al dramma degli attentati sono state la chiusura delle frontiere – misura che indica esplicitamente la volontà di proteggersi da una potenziale minaccia che viene dall’esterno – e la “Déchéanche de la Nationalité”, che indica la possibilità di far decadere il diritto di cittadinanza ai binazionali, rei sospettati di terrorismo. Tali misure sembrano esplicitare il tentativo giuridicamente fondato di negare ogni possibile legame, diretto o indiretto, con gli attentatori. Del resto, come suggerisce lucidamente Étienne Balibar, alla rivendicazione delle libertà democratiche si associa una negazione del loro effettivo esercizio a tutti coloro che non possono godere del diritto di cittadinanza.[2] L’umanitarismo universale della retorica libertaria trova qui il suo scacco finale e la sua principale contraddizione interna: il principio di libertà è prerogativa dell’essere umano, ma al contempo l’umanità stessa viene a coincidere con il pieno conferimento del diritto di cittadinanza.
Ma se l’attentato del 7 gennaio ha messo in crisi le rivendicazioni libertarie che si condensano nell’ideale di democrazia e cittadinanza prodotto dalla società moderna, quello del 13 novembre ha sollevato dubbi ancor più radicali che hanno messo più direttamente in questione il concetto stesso di umanità. È dunque intorno a questo dramma che la discriminazione antropologica ha trovato la sua piena risoluzione. Ripensare a quell’evento, riviverlo nella forma della commemorazione, significa trovare una cornice di senso che funge da modello esplicativo per tutti gli attentati ad esso assimilabili. Nella commemorazione si tratta di creare un orizzonte di pensabilità entro cui collocare questi ed altri simili episodi, di ricondurre la violenza efferata in un ordine di comprensibilità, di rinnovare la fiducia verso un ideale di giustizia universale e, infine, di ribadire un verdetto positivo sulla propria identità collettiva.
Per questo termini come “terrorismo islamico” o “islamismo radicale” servono a soddisfare sul piano sociale un’esigenza esplicativa, a riassorbire il senso di scandalo così come il senso di colpa, e a ridisegnare confini di umanità che coincidano con i limiti delle nostre appartenenze identitarie. Questi eventi, facilmente riconducibili alla dinamica di un massacro di massa, così come i genocidi, chiamano in causa il gruppo, mettono in dubbio lo statuto di umanità dei suoi membri, esigono la segregazione della barbarie in una dimensione di eccezionalità inumana. Allo stesso modo, la ferocia inammissibile dei massacri di massa scatena il timore di essere confusi con i carnefici, di condividere con loro una qualche parentela, di avere caratteristiche comuni che contrastano con i criteri morali di definizione della persona umana. In altri termini, lo spettro di un senso di responsabilità rimosso fonda l’inalienabilità morale della commemorazione e obbliga la società a inventare rappresentazioni e pratiche che gettino una distanza invalicabile tra l’identità del gruppo e quella degli attentatori. In questo modo l’ordine del mondo e l’immagine positiva di sé non vengono intaccati: l’evento è considerato opera di un’umanità degradata, non più degna di questo nome, da cui la collettività deve necessariamente prendere le distanze.

Il 13 novembre si è intriso di un significato mistico e sacrale, reso possibile dalla istituzione normativa della commemorazione. E così, attraverso il vincolo della memoria, il dramma del passato ha potuto legarsi all’ordinarietà del presente. Ad ogni anniversario, il ricordo del massacro riapre una ferita non del tutto rimarginata, lo shock ci assale nuovamente, fa irruzione nel presente e lo congela. È in questi termini che i partecipanti alla commemorazione del 13 novembre descrivono il proprio vissuto e i propri sentimenti nei confronti di quell’evento, riproponendo sul piano collettivo e sociale una sintomatologia psicopatologica che sul piano individuale si riferisce al disturbo post-traumatico da stress. In questo modo, il dramma del terrorismo viene riletto e rivissuto alla luce di una potente metafora onnicomprensiva, quella del trauma collettivo che interpreta la crisi sociale nei termini di una crisi d’identità. Come per il trauma psicologico – nozione che a sua volta deriva da una metafora che paragona lo shock emotivo a quello fisico – anche nel trauma collettivo, il ricordo dell’evento traumatico riaffiora potente, dopo un periodo più o meno lungo di rimozione e conservazione latente.
È interessante notare con Didier Fassin e Richard Rechtman che l’imposizione della metafora psicologica del trauma è storicamente coincisa con l’emergenza nella sfera pubblica della condizione di vittima.[3] Secondo gli autori, dal sospetto intorno alla sincerità della vittima di un trauma fino al pieno riconoscimento del suo valore qualcosa è cambiato nella storia del pensiero morale degli ultimi cinquant’anni: il trauma è diventato una chiave d’interpretazione dello shock della violenza, sia essa subita o perpetrata. Il trauma è diventato un referente trasparente e intelligibile a partire dalle rivendicazioni dei reduci dal Vietnam che avevano accusato una crisi psicologica e identitaria sviluppando tutta una serie di sintomi – come l’intrusione del ricordo della guerra, l’insonnia, la dipendenza dall’alcol e dagli stupefacenti, l’irritabilità – che solo in un secondo momento sono stati raggruppati e inseriti in un’unica categoria diagnostica. In seguito, i movimenti femministi in difesa delle donne vittime di violenze sessuali hanno avuto un ulteriore impatto politico sulla questione, contribuendo a consolidare la validità del quadro diagnostico e la sua accettabilità sociale. In seguito, dopo l’11 settembre, il significato di trauma si è arricchito di una connotazione ancora più ampia che ha aperto un varco alla concettualizzazione del trauma collettivo. Da questo momento l’attentato alle Torri Gemelli ha gettato nuova luce sui drammi del passato, primo fra tutti l’Olocausto, che solo allora è diventato l’evento commemorativo per eccellenza, fissando la pratica della memoria come norma e istituto morale.
Secondo questa lettura psicologizzante, oggi pienamente inserita nel quadro delle rappresentazioni condivise, il funzionamento sociologico del gruppo rimanderebbe al funzionamento psicologico dell’individuo. Tra individuo e società s’instaura un nesso di denotazione dove l’individuo rappresenta il segno e la società il referente. In questa prospettiva, i criteri di assegnazione dello statuto di umanità sono gli stessi per l’individuo e per la società e, in entrambi i casi, passano per la nozione di trauma. Il trauma è diventato così, sul piano individuale e collettivo, un dispositivo semiotico attraverso cui la società esprime il proprio verdetto di umanità. Vivere una violenza senza rimanerne turbati, è questa ai nostri occhi la mostruosità radicale. Il trauma, condizione patologica definita come normale reazione ad una situazione anormale, conserva quindi una doppia e ambigua valenza: serve a stabilire sia le condizioni di normalità per l’uomo sia il grado di violenza che l’essere umano è tenuto a sopportare senza subire danni psicologici. Tale impostazione logica produce un orizzonte etico particolarmente pervasivo, che investe la dimensione sociale e collettiva, suggerendo precisi parametri di assegnazione alla condizione umana. Se non si è stati vittime di violenza, per sentirsi pienamente umani occorre almeno identificarsi il più possibile con le vittime e allontanare dall’immagine di sé le figure degli attentatori. In questo senso ricordare le vittime significa stare dalla loro parte, condannare i carnefici e ribadire una presa di distanza netta contro la mostruosità della violenza.
 È per questa ragione che ad ogni tragedia la memoria viene rievocata come ordine supremo e inalienabile. E tuttavia esiste una scala delle priorità: il 13 novembre è diventato l’evento ultrarappresentativo di tutti gli attentati europei riconducibili a una matrice jihādista. Se da una parte non è pensabile dimenticare questa tragedia, d’altra parte il ricordo deve essere disciplinato socialmente. Stringersi intorno alla memoria della strage rinnova un senso di comune appartenenza ed esercita sul gruppo una funzione che è insieme politica e terapeutica. S’innesca così un dispositivo sociale che permette di consolidare l’immagine positiva del gruppo e l’ordine di senso e di valori da cui quest’immagine scaturisce. Infine, la cerimonia di commemorazione consente di arginare il dolore del ricordo, incanalandone la memoria in una versione definitiva, consentita e condivisibile. In questa cornice, così come il trauma individuale serve a ribadire lo statuto di umanità di chi lo porta, allo stesso modo solo una società che resta traumatizzata dalla violenza può sentirsi pienamente e legittimamente umana.
È per questa ragione che ad ogni tragedia la memoria viene rievocata come ordine supremo e inalienabile. E tuttavia esiste una scala delle priorità: il 13 novembre è diventato l’evento ultrarappresentativo di tutti gli attentati europei riconducibili a una matrice jihādista. Se da una parte non è pensabile dimenticare questa tragedia, d’altra parte il ricordo deve essere disciplinato socialmente. Stringersi intorno alla memoria della strage rinnova un senso di comune appartenenza ed esercita sul gruppo una funzione che è insieme politica e terapeutica. S’innesca così un dispositivo sociale che permette di consolidare l’immagine positiva del gruppo e l’ordine di senso e di valori da cui quest’immagine scaturisce. Infine, la cerimonia di commemorazione consente di arginare il dolore del ricordo, incanalandone la memoria in una versione definitiva, consentita e condivisibile. In questa cornice, così come il trauma individuale serve a ribadire lo statuto di umanità di chi lo porta, allo stesso modo solo una società che resta traumatizzata dalla violenza può sentirsi pienamente e legittimamente umana.
[1] Non è un caso che l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo abbia avuto una risonanza pubblica e mediatica ben più radicale e duratura rispetto al successivo attentato all’Hyper Casher. Ciò ha permesso di rivendicare il principio democratico della libertà di stampa per consolidare la propria legittimità morale e politica opponendola all’oscurantismo religioso del terrorismo islamico, come dimostrato dall’intensa partecipazione pubblica della manifestazione dell’11 gennaio e della risonanza mediatica di livello internazionale del famoso slogan “Je suis Charlie”. Per approfondire la questione in modo semplice e gratuito si consiglia di leggere Scritti dopo gli attentati di Parigi, raccolta di saggi disponibile on line sul sito di Nazione Indiana e Alfabeta2:
https://www.nazioneindiana.com/2015/05/08/scritti-dopo-gli-attentati-di-parigi-un-e-book-di-nazione-indiana/ [consultato il 15/01/2017, alle ore 15:16].
https://www.alfabeta2.it/2015/05/10/scritti-dopo-gli-attentati-di-parigi/
[consultato il 15/01/2017, alle ore 15:17].
Si segnalano in particolare i seguenti contributi :
BADIOU, Alain, Il Rosso e il Tricolore, in: Nazione Indiana, Alfabeta2, “Scritti dopo gli attentati di Parigi”, Quaderni, 2015;
GALLO LASSERE, Davide, Oltre Charlie, in: Nazione Indiana, Alfabeta2, “Scritti dopo gli attentati di Parigi”, Quaderni, 2015;
INGLESE, Andrea, Note su “Io sono Charlie” e il suo contraltare, in: Nazione Indiana, Alfabeta2, “Scritti dopo gli attentati di Parigi”, Quaderni, 2015.
[2] BALIBAR, Étienne, Cittadinanza, Bollati Borghieri, Torino, 2012.
[3] FASSIN, Didier, RECHTMAN, Richard, L’empire du traumatisme, Enquête sur la condition de victime, Flammarion, Parigi, 2007.













