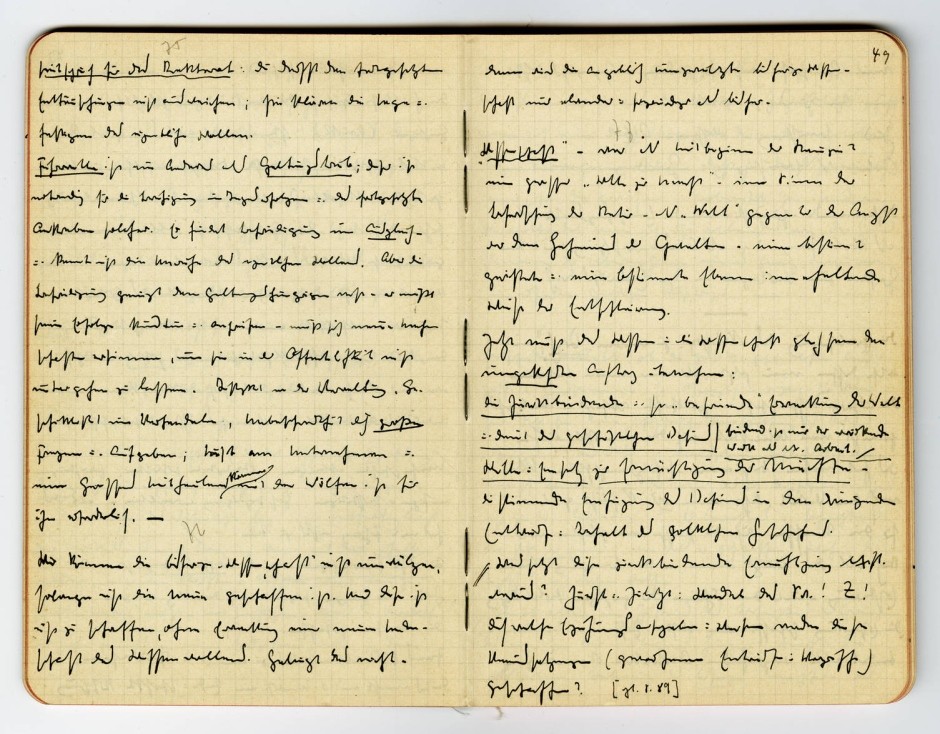I.
Minnie (corrispondenza da Genova)
Al porto antico, verso le otto della sera, un piccolo capannello di bambini e di mammapapà si è formato poco dietro il bigo, dove turisti non fanno che andarsene su e giù giù e su: c’è una Minnie, con il suo vestitino bianco a pois rossi, che fa da attrazione. Muta, regala palloncini ai più piccoli, che lo accettano incerti, per un istante infinito, se quella sia davvero Minnie oppure no. Ma l’imitazione ― se c’è ― è perfetta, iperrealtà di marca Disneyland in cui la finzione (la realtà di una Minnie esistente, in carne e costume) riproduce un’altra finzione (la Minnie “reale”, che non esiste). Con la conseguenza che è più reale la Minnie che chiede soldi al porto antico che non la “vera” Minnie ― personaggio di fantasia, impossibile. Già Augé lo aveva detto benissimo: quintessenza del turismo, dove ciò che si viene a visitare in realtà non esiste (ma non vale anche per questo ascensore panoramico, per questa Genova d’angiporto che non può essere descritta se non attenendosi ad un lessico prefabbricato?). Per questo i genitori ridono come bambini (ma non: come “i” bambini), si divertono intorno a questa Minnie dalla faccia fatta di plastica, immagine che non riflette la realtà, ma nasconde la sua assenza (Fernet).
Anche noi ― un piccolo gruppetto di tre trentenni ― sorridiamo fermandoci a guardare la fidanzata di Topolino, con le sue orecchie enormi, ed i bambini che, spinti dai genitori, le si avvicinano, si fanno abbracciare, corrono intorno a lei, con i loro soldini tra le mani. Minnie saluta, con i suoi guantini neri, ringrazia, sempre muta, chinando il capo enorme, alla luce dorata del tramonto. Adulti applaudono ancora. Ci spostiamo poco più avanti, a osservare la scena dai tavolini di un caffè. Minnie si muove seguendo il ritmo di una musichetta Disney che esce dal piccolo stereo, obsoleto, che ha portato con sé, mickeymouseggiando un po’, diventando la propria immagine animata. Fa sedere i bambini in cerchio, li incanta con qualche bolla di sapone e agitando un po’ le sue manine; si inchina, saluta, fabbrica la loro infanzia, saluta ancora. Soldini ― per comprare l’infanzia ai genitori ―, nuovo inchino. Lo spettacolino termina, poco dopo. La folla si disperde, è il momento dei gelati e della nanna. Minnie raccoglie le sue cose, conta gli spiccioli, si guarda intorno. Finalmente, ora che non c’è più nessuno in giro, può togliersi la maschera di plastica: incrocio gli occhi splendenti di una ragazzina Rom. Sorride: ha i denti marci. Sorride ancora, e se ne va.
Morale della favola: gli zingari non rapiscono i vostri bambini per mandarli a chiedere l’elemosina. Hanno forse capito che è più pratico ― e meno rischioso ― farsi fare l’elemosina direttamente da loro. Fantasmi del sogno disneyano: dietro ogni Minnie, ogni Topolino, c’è uno zingaro, a ricordarvi che la vostra infanzia è sempre falsa. Ho sorriso anche io, alla ragazzina Rom.
II.
La fine dei nomi.
Ho passato Ferragosto senza nomi. Senza, cioè, più vedere i nomi, le cose, ma solo il libero gioco dei verbi, delle azioni. Si comincia chiedendosi: e se i nomi fossero, in realtà, verbi, se esprimessero cioè azioni, e non “cose”, “sostanze”, soggetti? Qui serve una breve spiegazione: quando affermo che “S è P” (es: quel cavallo è veloce), ciò che sto facendo è predicare una qualità, un attributo (veloce) ad un soggetto (il cavallo). Questo rapporto di predicazione sembra allora separare le “sostanze”, le “cose” (il cavallo, Socrate, una rosa) ― che esistono di per se stesse ― dai vari predicati che accidentalmente possono o meno avere (la rosa può essere bianca, o rossa, o gialla, ma non è il colore a farne ciò che è, ossia una rosa). Ci sono diverse “strategie” concettuali per criticare questa tesi. Ma non è questo il punto. Esercitiamoci piuttosto sulla domanda: e se anche i “soggetti” fossero predicati, e viceversa? Differenti filosofie lo suggeriscono (potremmo chiamarle, anche se impropriamente, filosofie del divenire, anticartesiane, antisostanzialiste). Sbaglieremmo, però, a considerare questa tesi come “intellettualistica” ― essa implica infatti una pratica, un impegno quotidiano concreto, un esercizio che chiunque può cominciare a svolgere. Proviamoci. Riprendiamo la nostra frase: “quel cavallo è veloce”. Siamo abituati, troppo abituati a pensare, a vedere direi, un cavallo ― considerandolo un ente, una sostanza, qualcosa che è ― e a cercare un “aggettivo” che esprima una sua “qualità”, l’essere veloce. È così che “vediamo” il mondo ― separando continuamente i soggetti dai loro predicati. Ma se cambiassimo improvvisamente questo schema? Perché devo dire che “il cavallo è veloce”, e non che la “velocità è cavallina”? Sarebbe una follia? In fondo, soggetto e predicato sono solo “posizioni” all’interno della frase. Perché non dovrei poterli invertire? Perché non far divenire i soggetti dei predicati? Ma il nostro è un esercizio, e non una discussione teorica. Chiediamoci pertanto: come mi apparirebbe allora il mondo? Come lo vedrei? Immaginatevi di non percepire più un cavallo, e di pensare che è veloce, ma di provare a percepire la velocità che diviene un cavallo, si incarna, si rende visibile facendosi cavallo. Ciò non significa semplicemente affermare che ora la velocità è il “soggetto” ― essa resta verbo, predicato, e solo per convenzione la mettiamo in posizione di soggetto. Ad essere precisi dovremmo cioè vedere il divenire-velocità del cavallo e allo stesso tempo il divenire-cavallo della velocità (tenetelo presente, perché non potrò precisarlo per ogni esempio, per ragioni di spazio e leggibilità). Oppure pensate ai girasoli di Van Gogh. Sarebbe del tutto ridicolo affermare che i suoi girasoli sono gialli (chiunque di voi potrebbe ridipingerli uguali, se fosse così). Ciò che vedete, infatti, è il giallo che diviene-girasole, è il colore che si rende visibile non nel suo essere un “attributo”, una “qualità”, ma nel suo essere verbo, azione, azione di rendersi un girasole. Molta pittura, molto cinema, molta letteratura non si capirebbero, senza questa “inversione”. Forse però tutto questo sembra ancora troppo astratto. Ma solo perché non siamo disposti, quotidianamente, a sperimentare questo strano movimento concettuale: accade come se tutto ciò che solitamente pensiamo come sensazione, azione, idea, prendesse corpo, divenisse concreto, togliendo sostanza e materia alle “cose”, ai nostri “nomi”. Peirce consigliava di riservare mezz’ora al giorno al “musement”, al libero gioco dei pensieri, dove unica regola fosse quella di non avere regole. E se provassimo, magari per mezz’ora al giorno, a guardare il mondo così, osservando ciò che ci circonda, provando a descriverlo e poi a rovesciare o invertire quella descrizione, cercando di trasformare in verbi tutte le parti della proposizione? Ma per quale ragione lo consiglio? In fondo, perché è sempre bene non dare troppo peso alle “cose” ― datelo ai verbi, e a questo mondo stralunato e leggerissimo.